Gli approfondimenti del giorno
Primato del diritto comunitario su quello nazionale: lo ribadisce la Corte UE
Per abbonati
La Corte di giustizia comunitaria ha esaminato una questione pregiudiziale sollevata dalla…
Il modus operandi delle imprese nella diversità dei contesti culturali: il caso saudita
La cultura organizzativa, elemento centrale nella gestione aziendale, non è stata sempre…
Il Governo proporrà un disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale – Diario Quotidiano 26 Aprile 2024
Per abbonati
Nel DQ del 26 Aprile 2024:
1) CDM: decisioni prese, dall’intelligenza artificiale alla…
1) CDM: decisioni prese, dall’intelligenza artificiale alla…
Il rapporto biennale uomo – donna 2022-2023
In Italia, l’attenzione alla parità di genere nel mondo del lavoro sta…
Gli effetti della mancata o tardiva comunicazione all’ENEA
Per abbonati
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, discostandosi da un precedente (e…
Depositario delle scritture contabili: il modello per recedere dall’incarico
Per abbonati
Modello e relative istruzioni per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessazione…
Il ricatto dei rimborsi fiscali: la compensazione volontaria diventa compensazione forzata
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del…
Breaking News
Bonus cultura 18 app: acquisti da completare entro il 30 aprile
Entro il 30 aprile, gli interessati (ragazze e i ragazzi nati…
ZES: in arrivo il decreto attuativo delle agevolazioni
E’ in arrivo il decreto attuativo del Dl Sud n.124/2023 che…
Regime premiale Isa 2023: le regole di accesso
Con il provvedimento prot. n. 205127/2024 del direttore dell’Agenzia del 22…
Ultimi articoli
Gli articoli più letti
Gli articoli più letti della nostra rivista
Il patto di famiglia: i risvolti fiscali
L’articolo analizza gli aspetti fiscali del patto di famiglia, evidenziando l’assenza di una normativa tributaria…
Verifica dell’obbligo di contabilità di magazzino con decorrenza dal 1° gennaio 2024
Si avvicina la fine dell’anno e i contribuenti che hanno superato i limiti devono far…
Trattamento fiscale degli omaggi di fine anno: una guida approfondita
Con l’avvicinarsi delle feste natalizie e di fine anno le imprese/professionisti sovente concedono omaggi a…
Reverse charge: sanzioni applicabili per omessa registrazione delle autofatture
Oggi analizziamo un caso particolare, ma sentito, di sanzioni tributarie: quello relativo alla omessa emissione…
La rappresentazione in bilancio del ristorno nelle società cooperative
La rappresentazione del ristorno in bilancio nelle cooperative è dibattuta: alcuni lo vedono come un…
Finanziamento di SRL da parte di soggetto terzo estraneo alla società
Il Tribunale di Roma ha stabilito che i finanziamenti da terzi a una SRL sono…
Le regole per emettere la nota di credito: il caso della fattura per acconto poi stornata
Analizziamo il caso pratico di uno storno per forniture non effettuate, a fronte di un…
Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: strumenti operativi
In tema di adeguati assetti aziendali si è mosso anche l’Ordine dei Commercialisti che ha…
Il conferimento in società dell’azienda gestita in impresa familiare
Approfondiamo il particolare caso del conferimento dell’impresa familiare in una società: puntiamo il mouse sulle…
Donazioni pregresse nel coacervo, rivalutazione e franchigia
Proponiamo un’analisi della possibilità di rivalutazione delle donazioni pregresse nel contesto dell’imposta sulle donazioni e…
Vendita di immobile post assegnazione in presenza di ulteriori atti societari
La vendita di un immobile successivamente alla assegnazione agevolata non costituisce abuso del diritto, e…
L’utilizzabilità del credito da dichiarazione integrativa, anche in caso di riconoscimento di maggior credito da avviso bonario
In caso di maggior credito emergente da un avviso bonario qual è la via migliore…
Il principio contabile OIC 34 e le vendite con obbligo di riacquisto
Una delle novità inserite nel nuovo OIC 34 riguarda le vendite con obbligo di riacquisto….
Il monitoraggio delle criptoattività secondo il Fisco
E’ stato pubblicato il testo definitivo della circolare dedicata a criptovalute e criptoattività: vediamo quali…
Le comunicazioni delle holding all’anagrafe dei rapporti
Uno degli adempimenti specifici delle holding è l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria: quali sono i…
I nostri corsi
Scopri la nostra formazione online e a distanza.
Nuovi e utili
Dai un occhiata ai nuovi prodotti.
Best seller
I nostri best seller
-
 Percorso On Demand | Corso IAS/IFRS: i principi contabili internazionaliProdotto in vendita650,00 € + I.V.A
Percorso On Demand | Corso IAS/IFRS: i principi contabili internazionaliProdotto in vendita650,00 € + I.V.A450,00 € + IVA per gli Abbonati
-
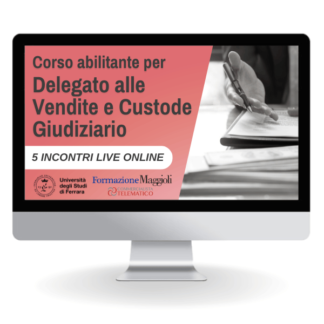 Corso abilitante per Delegato alle Vendite e Custode GiudiziarioProdotto in vendita550,00 € + I.V.A
Corso abilitante per Delegato alle Vendite e Custode GiudiziarioProdotto in vendita550,00 € + I.V.A -
 Corso Online Registrato | Corso IVA 2023: Casi particolari di applicazione dell’IVAProdotto in vendita66,50 € + I.V.A
Corso Online Registrato | Corso IVA 2023: Casi particolari di applicazione dell’IVAProdotto in vendita66,50 € + I.V.A85,00 € + IVA per gli Abbonati
-
 Corso Online Registrato | Corso IVA 2023: Ecommerce e IVAProdotto in vendita85,50 € + I.V.A
Corso Online Registrato | Corso IVA 2023: Ecommerce e IVAProdotto in vendita85,50 € + I.V.A85,00 € + IVA per gli Abbonati


























