Uno degli strumenti chiave adottati dall’UE per ridurre l’impronta carbonica è il CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Dal 2026, le imprese che importano in Europa dovranno rendicontare le emissioni incorporate nei prodotti e acquistare certificati per compensarle. Un cambiamento che riscrive le regole del commercio globale.
CBAM tra diritto ambientale e commerciale: le nuove frontiere del commercio internazionale
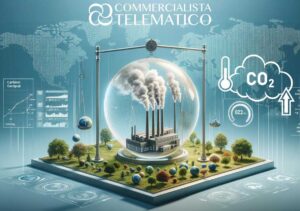
La logica sottesa al meccanismo CBAM prevede l’obbligo, per le imprese interessate dai nuovi adempimenti, di rendicontare le emissioni assorbite nei prodotti importati e, a partire dal 2026, il vincolo di acquistare determinati certificati per compensare il carbonio incluso in tali prodotti.
Evidentemente con questi nuovi adempimenti si creano effetti rilevanti sia sulle logiche di approvvigionamento sia sulla competitività delle imprese.
Il CBAM è stato istituito col Regolamento (UE) 2023/956 e trova la sua ratio nella necessità di risolvere il fenomeno del “carbon leakage” (vale a dire la “divergenza carbonica”). Accade, infatti, che la produzione ad alta intensità di CO2 verso paesi con giurisdizioni e politiche climatiche meno restrittive, comprometta l’efficacia globale delle politiche di decarbonizzazione europee.
Il meccanismo di aggiustamento carbonico mira, pertanto, a ripristinare condizioni di parità competitiva tra produttori europei e di paesi terzi, uniformando il prezzo del carbonio incorporato nei prodotti importati a quello sostenuto dai produttori europei.
Base giuridica del CBAM e funzionamento
Il Regolamento CBAM trova la propria ragion d’essere nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che consente l’adozione di misure finalizzate alla tutela dell’ambiente. Tale collocazione normativa sottolinea la natura ambientale dello strumento, piuttosto che commerciale, cercando di disinnescare le critiche che lo interpretino come un sistema protezionistico dell’Ue. La questione della compatibilità del CBAM con le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), infatti, ha suscitato un vivace dibattito. Il CBAM si distingue per la sua natura ibrida e interfunzionale: esso non è un’imposta doganale in senso stretto, né un dazio, bensì un meccanismo regolatorio parafiscale, che incide sia sull’equilibrio concorrenziale interno che sugli scambi internazionali.
Il Regolamento (UE) 2023/956 delinea un’architettura normativa articolata e progressiva, che prevede una implementazione del meccanismo in due fasi:
- Prima fase transitoria (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025), durante la quale gli importatori sono tenuti esclusivamente a obblighi di comunicazione delle emissioni incorporate nei prodotti importati, senza oneri finanziari;
- Seconda fase operativa (a partire dal 1° gennaio 2026), comporterà l’acquisto di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati. Dal 2027, con riferimento il 2026, inoltre, i dichiaranti CBAM dovranno presentare una dichiarazione, entro il 31 maggio di ogni anno, per poter importare le merci nel territorio della Ue.
Per ottenere la qualifica di dichiarante autorizzato ai fini del CBAM, l’importatore – o, nel caso in cui non abbia sede in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto che opera per suo conto – dovrà inoltrare una specifica richiesta all’autorità competente dello Stato UE interessato.
L’autorità, entro i termini previsti, procederà a effettuare le opportune verifiche istruttorie e, qualora ne sussistano i requisiti, disporrà l’inserimento del richiedente nell’apposito registro dei dichiaranti CBAM.
Una volta ottenuto lo status autorizzato, gli operatori registrati saranno soggetti a una serie di obblighi regolamentari, tra cui:
- La quantificazione delle emissioni di anidride carbonica incorporate nei prodotti CBAM importati, mediante l’applicazione di metodologie conformi alla normativa europea. La documentazione tecnica a supporto dei calcoli dovrà essere conservata e le emissioni dovranno essere certificate da organismi accreditati e indipendenti;
- L’acquisto di certificati CBAM in misura corrispondente alle emissioni incorporate nei beni importati durante l’anno solare precedente. Tali certificati, equivalenti a una tonnellata di CO₂ ciascuno, saranno accessibili attraverso una piattaforma centralizzata gestita dalla Commissione europea, e il prezzo sarà determinato sulla base della media settimanale delle quote Emissions Trading System (ETS). Inoltre, alla fine di ogni trimestre, i dichiaranti dovranno garantire che il numero di certificati detenuti sul proprio conto CBAM copra almeno l’80% delle emissioni associate alle importazioni effettuate dall’inizio dell’anno in corso.
Settori interessati e criteri di inclusione
Il CBAM si applica inizialmente a una serie limitata di settori ad alta intensità energetica e significativa esposizione al rischio di carbon leakage come, ad esempio, cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. La selezione di tali settori è sollecitata sulla base di criteri quali l’intensità delle emissioni, il grado di esposizione alla concorrenza internazionale e la fattibilità amministrativa. La gradualità dell’approccio adottato dalla Commissione corrisponde alla necessità di bilanciare ambizioni climatiche e praticabilità implementativa, consentendo l’affinamento del meccanismo prima della sua estensione ad ulteriori settori. Il Regolamento prevede, infatti, una clausola di revisione che contempla la possibile inclusione di prodotti a valle e di altri settori, in funzione dell’esperienza maturata nella fase iniziale.
Tale approccio è stato criticato per le potenziali difficoltà implementative legate all’asimmetria informativa e ai costi amministrativi per gli operatori dei paesi terzi, particolarmente gravosi per le PMI e per i produttori dei paesi meno sviluppati.
Il pacchetto “Omnibus” della Commissione Europea del 26 febbraio 2025, inoltre, ha suggerito la proposta di modifiche rilevanti e riduttive al CBAM, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia, ridurre le distorsioni di mercato e aumentare la compatibilità con le regole dell’OMC (WTO). La proposta di revisione del Pacchetto Omnibus prevede, infatti, una possibile limitazione dell’ambito applicativo del CBAM, circoscrivendolo alle imprese che importano annualmente almeno 50 tonnellate di uno dei beni disciplinati dal regolamento.
Impatto sulla competitività industriale europea
L’adozione del CBAM comporta notevoli implicazioni per la competitività dell’industria europea, con diversi effetti in funzione delle caratteristiche specifiche dei singoli settori. Le analisi econometriche suggeriscono che, nel breve periodo, il meccanismo potrebbe comportare un incremento dei costi di approvvigionamento per le imprese europee sottoposte al CBAM, con potenziali conseguenze negative sulla loro competitività nei mercati globali.
D’altro canto, nel medio-lungo termine, il CBAM potrebbe stimolare l’innovazione tecnologica e l’efficientamento dei processi produttivi, contribuendo al consolidamento del vantaggio competitivo europeo nei settori delle tecnologie a basse emissioni di carbonio.
Le ripercussioni del CBAM sul commercio internazionale e sulle relazioni con i partner commerciali dell’UE sono oggetto di particolare attenzione. Le simulazioni effettuate indicano una potenziale riduzione delle importazioni europee nei settori interessati dal meccanismo, con effetti asimmetrici sui diversi paesi esportatori, in funzione dell’intensità carbonica della loro produzione e della rilevanza del mercato europeo per le loro esportazioni.
I paesi emergenti ad alta intensità carbonica, come Cina, Russia e India, hanno manifestato ovviamente forti critiche nei confronti del CBAM, interpretandolo come una misura protezionistica mascherata da strumento ambientale.
Criticità applicative e prospettive evolutive
L’efficacia del meccanismo dipenderà dalla capacità di predisporre un sistema di monitoraggio, reporting e verifica delle emissioni incorporate che bilanci rigorosità scientifica e fattibilità amministrativa. Particolarmente complessa appare la gestione delle catene di approvvigionamento globali, caratterizzate da elevata frammentazione geografica e complessità organizzativa. In tale contesto, la tracciabilità del contenuto di carbonio lungo la supply chain e l’allocazione delle relative responsabilità costituiscono limiti metodologici di non agevole soluzione. I meccanismi di carbon border adjustment potrebbero stimolare le coalizioni di paesi che adottano politiche climatiche green e impongono tariffe sulle importazioni da paesi non aderenti. In tale ottica, il CBAM potrebbe evolvere da strumento ambientale a elemento costitutivo di un approccio coordinato alla carbon pricing globale. Tale evoluzione implica, tuttavia, un significativo intensificarsi della cooperazione internazionale e la progressiva convergenza verso standard condivisi per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni incorporate nei prodotti.
Di particolare rilevanza strategica appare l’interazione tra il CBAM e gli standard di sostenibilità emergenti dal quadro della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). L’integrazione tra gli obblighi informativi del CBAM e il più ampio framework della rendicontazione di sostenibilità potrebbe generare significative sinergie, contribuendo alla standardizzazione delle metodologie di carbon accounting e alla riduzione dei costi di compliance per gli operatori economici.
Conclusioni e scenari
Il CBAM rappresenta un’innovazione significativa nell’architettura delle politiche climatiche europee, caratterizzata da un elevato grado di complessità tecnica e sensibilità politica. La sua implementazione richiederà un continuo affinamento metodologico e un’attenta gestione delle relazioni con i partner commerciali dell’UE.
Per le imprese europee operanti nei settori interessati, il CBAM comporta la necessità di sviluppare competenze avanzate nel carbon management e nella gestione della supply chain in ottica di sostenibilità. L’integrazione della carbon footprint nei processi decisionali strategici e operativi costituisce un fattore di resilienza e competitività nel contesto della transizione ecologica.
Per i legislatori, la sfida consiste nel calibrare il meccanismo in modo da massimizzarne l’efficacia ambientale, minimizzando al contempo i potenziali effetti distorsivi sul commercio internazionale e i costi amministrativi per gli operatori economici. Tale obiettivo richiede un approccio adattativo, basato sul monitoraggio continuo degli impatti e sulla disponibilità ad apportare correzioni in itinere. Il successo del CBAM dipenderà dalla sua capacità di contribuire efficacemente alla decarbonizzazione dell’economia globale, fungendo da elemento propulsivo per l’innovazione tecnologica e per il progressivo allineamento delle politiche climatiche a livello internazionale, piuttosto che come mero strumento di protezione dell’industria europea dalla concorrenza estera.
NdR: potrebbero interessarti anche…
I nuovi paradigmi dell’attestazione di sostenibilità
Le semplificazioni proposte dalla Commissione Europea in materia di sostenibilità
CBAM: il nuovo dazio ambientale sulle importazioni
Fabio Sartori
Sabato 5 aprile 2025
Redazione passo-passo del Bilancio di Sostenibilità sulla base del VSME ESRSWebinar in diretta online
Per tutte le imprese fino a 1.000 dipendenti la Commissione proporrà con atto delegato uno standard basato sul VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) predisposto da EFRAG. Inoltre, la stessa Commissione propone di limitare le informazioni che le imprese di maggiori dimensioni e gli istituti di credito possono richiedere con riferimento alle variabili ESG: anche in questo caso, per tutti i soggetti con meno di 1.000 dipendenti, le richieste saranno limitate a quelle previste dallo standard VSME. Lo standard VSME assume pertanto un ruolo centrale nella rendicontazione di sostenibilità e diviene uno strumento fondamentale sia per i Dottori Commercialisti e consulenti aziendali che intendono supportare i propri clienti nella redazione del bilancio di sostenibilità, sia per i CFO, i CSO e i manager della sostenibilità che devono acquisire competenze adeguate per gestire i fattori ESG della propria organizzazione e della propria catena del valore. Il webinar, dal taglio operativo e basato su un approccio learning by doing con utilizzo di fogli di calcolo e modelli di redazione, si propone di trasmettere ai partecipanti strumenti utili per la redazione del bilancio di sostenibilità sulla base della versione finale dello standard VSME emanato da EFRAG nel mese di dicembre 2024. CREDITI: in fase di accreditamento ODCEC SCOPRI DI PIU’
|

 Il recente pacchetto Omnibus I della Commissione Europea (documento del 26 gennaio 2025) propone una radicale modifica dello scenario del reporting di sostenibilità: il numero di imprese obbligate a redigere la Rendicontazione di Sostenibilità sulla base degli standard ESRS si ridurrà drasticamente e numerosi adempimenti verranno semplificati.
Il recente pacchetto Omnibus I della Commissione Europea (documento del 26 gennaio 2025) propone una radicale modifica dello scenario del reporting di sostenibilità: il numero di imprese obbligate a redigere la Rendicontazione di Sostenibilità sulla base degli standard ESRS si ridurrà drasticamente e numerosi adempimenti verranno semplificati.