Analizziamo il delicato tema dei ristorni ai soci nel mondo cooperativo: deve esistere un limite a quanto la cooperativa può concedere come ristorno ai propri soci oppure vale l’autonomia statutaria?
La questione sul piano dello stretto diritto riguarda in primis l’inquadramento dogmatico del diritto al ristorno ordinariamente concepito come una modalità di attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico.
Proprio tale scopo rende instaurabile tra il ristorno e la società cooperativa una sorta di rapporto di immedesimazione di scopo, nel senso che il ristorno costituisce lo strumento attuativo dello scopo mutualistico della società.
Già da tale rapporto osmotico tra la speciale configurazione societaria della cooperativa ed il ristorno non può non apparire un dissidio di comune logica giuridica ritenerlo sottoposto a limiti quantitativi, perché un tale limite sortirebbe concettualmente l’effetto riflesso di limitare anche il perseguimento dello scopo mutualistico che costituisce la fondamentale delineazione strutturale e disciplinare della cooperativa.
Una chiara sorta di corto circuito di logica giuridica solo idoneo a snaturare la cooperativa della sua chiara natura teleologica.
In sede di revisione delle cooperative nasce sempre il problema della determinazione del ristorno, che il revisore ritiene possa essere fatto derivare dall’avanzo di gestione procurato dall’attività mutualistica con i soci e a tale metodo si è adeguata la prassi. Non condividendo tale criterio di determinazione del ristorno, che peraltro non è supportata dalla riforma societaria ho ritenuto di predisporre questo approfondimento.
I limiti alla distribuzione di utili da parte delle cooperative
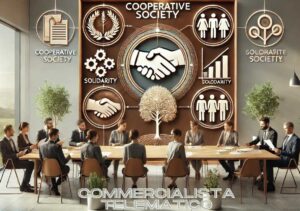
Proprio il fatto che il legislatore incapsuli in limiti ben precisi l’ammontare del dividendo distribuibile, mentre non dispone di limiti quantitativi in ordine alla distribuzione del dividendo (art 2545 sexies c.c.), conforta quanto sopra esposto, ossia che la dilatazione dell’ammontare dei ristorni distribuibili si coniuga con lo scopo della cooperativa, esternandone la corretta esecuzione contrattuale. L’idea della necessaria provenienza dei ristorni dalle entrate derivanti da rapporti che la società ha intrattenuto con i propri soci per non snaturare lo scopo mutualistico della cooperativa, non può non apparire del tutto contrariata dalla considerazione che è proprio il ristorno a costituire lo scopo mutualistico, per cui qualsiasi soglia limitativa del ristorno non può non rappresentarsi come incoerente proprio rispetto al primario fondamento causale della mutualità della cooperativa.
I ristorni nelle cooperative
In altri termini, se lo scopo mutualistico fonda il fine giustificativo della cooperativa e se il ristorno ne costituisce lo strumento attuativo, limitare la distribuzione del ristorno, una volta effettuati gli stanziamenti di legge, può solo sortire il significato di menomare il perseguimento della mutualità e con esso lo scopo costitutivo della cooperativa, dando origine ad un sillogismo di manifesta incoerenza, censurabile sotto il profilo del criterio costituzionale della ragionevolezza (art 3 Cost.).
Un conto, quindi, come chiaramente traspare dall’indagine dell’art 2545 sexies, è la considerazione di limiti qualitativi alla base della distribuzione dei ristorni (una volta già determinati) che non può che condividere l’entità e la qualità delle prestazioni ausiliarie dei soci, mentre altro è che la distribuzione quantitativa del vantaggio mutualistico debba derivare dalla sola parte di avanzo di gestione procurata dall’ attività intercorsa tra la cooperativa ed i propri soci (con esclusione, quindi, della frazione dell’avanzo di gestione generata dall’attività con i terzi) che non incontra invece limiti di sorta nell’art 2545 sexies cod, civ..
La dottrina (si confronti tra gli altri Giorgio Marasà, “Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario” Cedam Editore) raccorda l’essenza della mutualità a quanto risulta dalla relazione al codice civile, ossia come risultato economico, diverso dallo scopo di lucro, da commutare in un vantaggio remuneratorio per i soci maggiore di quello ritraibile dal mercato. Tutta l’azione imprenditoriale della cooperativa è tesa a tale fondamentale scopo e qualsiasi deviazione dal medesimo non può che rappresentarsi in antitesi alla sua natura. Anche se le cooperative partecipano ad un sistema, la mutualità, nel suo ordinario paradigma, non è rinvenibile nel rapporto tra cooperativa e sistema, ma solo tra cooperativa e la propria categoria di soci (G. Presti, “Società cooperative” Giuffrè Ed.).
Analisi della norma civilistica
L’indagine dell’art 2545 sexies appare del tutto allineato a quanto sopra esposto. Dalla riforma societaria del 2003 deriva la conferma del ristorno nella sua definizione tradizionale corrispondente ad un modo differito di attribuzione del vantaggio mutualistico, secondo la definizione già desumibile dalla Relazione al codice civile del 1942.
Aspetto fondamentale è che con la riforma del 2003 il ristorno non è più una nozione del diritto tributario e rilevante per il medesimo, ma ha assunto una dignità autonoma per il diritto societario della cooperazione, Non è infatti parso e non potrebbe apparire corretto far dipartire la nozione di ristorno secondo le considerazioni del legislatore tributario o della prassi dell’Amministrazione Finanziaria e riversarle nell’ordinamento societario della cooperazione. Un animato dibattito sull’istituto si è svolto nel primo semestre del 2002 nell’ambito della Commissione Vietti e tale confronto ha riguardato in particolare i rapporti quantitativi tra utili e ristorni, la natura di questi ultimi, il diritto al vantaggio mutualistico dei soci nella forma del ristorno e dell’incidenza della concreta politica di utilizzo dei ristorni per la definizione dello statuto della cooperazione agevolata.
Di tale dibattito vi è anche traccia nella Relazione ministeriale dell’art 2545 sexies ove si rinviene la precisazione: “si è scelta una versione sintetica della norma con un rinvio alla disciplina statutaria”, L’indicata Relazione, che sintetizza il confronto tra le diverse posizioni nel corso dei lavoratori preparatori, evidenzia alcune specifiche conseguenze di ordine normativo:
- L’abbandono di versioni più analitiche della disciplina del ristorno;
- La riduzione al minimo dell’ambito di imperatività della disciplina, con rimessione all’autonomia privata in punto di determinazione, spettanza e modalità di attribuzione dei ristorni:
- L’irrilevanza per la disciplina legale dei ristorni, dell’appartenenza della cooperativa al settore della cooperativa agevolata o diversa.
Per quanto concerne l’interpretazione dell’art 2545 sexies appare chiaro che il legislatore ha inteso escludere l’esistenza di un rapporto predeterminato per legge tra dividendi e ristorni. Inoltre appare di fondamentale importanza, proprio sul piano di un’ermeneutica oggettiva, dell’art. 2545 sexies, la considerazione che la norma non definisce il ristorno come
“avanzo di gestione derivante dalla gestione mutualistica con il socio”,
per contrapporlo all’utile derivante dalla gestione dell’impresa con i terzi.
In dottrina si sottolinea come la nozione giuridicamente rilevante di ristorno debba con la riforma del 2003 essere ricavata soltanto dal comma 1 dell’art 2545 sexies che raccorda la ripartizione dei ristorni secondo criteri diversi da quelli dei dividendi, determinati nell’atto costitutivo “proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici”.
Tale ultimo inciso è solo indicativo dell’obbligatorietà del parametro di riferimento per l’attribuzione dei ristorni, senza nulla dire in ordine al quantum distribuibile.
La similitudine dividendi ristorni
In altri termini ancora, la fattispecie legislativa in esame s’incentra unicamente sulla funzione del ristorno come strumento di ridistribuzione della ricchezza in un’ottica di mutualità, non correlabile al criterio capitalistico della remunerazione del capitale, senza prevedere soglie limitative nella distribuzione dell’avanzo di gestione, salvo la nettizzazione degli stanziamenti di legge.
Dal punto di vista dell’interpretazione obiettiva dell’art 2545 sexies, comma 1 c.c. ( a mente del quale: “L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici”) non appare possibile negare che il solo elemento in esso individuato, alla base dell’attribuzione del ristorno, consista nella ripartizione dell’avanzo di gestione secondo criteri non capitalistici, ma statutariamente ancorati alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intercorsi con i soci. Criterio, quindi, solo qualitativo in nulla affine ad un criterio quantitativo.
Le ragioni della mutualità, nell’accezione che ora risulta dalla nuova disciplina codicistica della cooperazione, vanno ricondotte ad una legittima aspettativa dei soci in ordine ad una tecnica di distribuzione dell’avanzo di gestione nella forma del ristorno che consideri la qualità e la quantità del concorso di ogni socio alla dinamica di mercato della cooperativa. Il legislatore non ha preso alcuna posizione in ordine ad eventuali limiti all’attribuzione del ristorno demandando semmai all’autonomia statutaria la relativa fissazione, con la sola previsione in leggi speciali di talune soglie limitative (come in ordine al ristorno attribuibile al socio lavoratore, la cui misura di ristorno, in virtù dell’art 3, comma 2, lett.. b, legge n 142/2001, non può eccedere il 30%dei trattamenti retributivi complessivi di derivazione contrattuale).
Esistono limiti ai ristorni?
Ma è proprio da tali deroghe che non può non promanare la possibile dilatazione del quantum del ristorno all’intero avanzo di gestione nettizzato degli stanziamenti obbligatori. La deroga si risolverebbe in tam quam non esset, se poi sulla base di qualche surrettizia regola pregiuridica si ritenesse di ampliare in termini generali i limiti quantitativi della distribuzione del ristorno.
Determinanti appaiono essere in tal senso i riferimenti che compaiono nell’ambito della legge delega ove è dato rinvenire un riferimento esplicito al “ristorino in favore dei soci cooperatori” (art 5, paragrafo 2, lett. a) che prescrive di tener conto, nella definizione della relativa disciplina, della necessità di assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela patrimoniale ed amministrativa, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori e “riservando i più ampi poteri all’autonomia statutaria”. Le norme delegate (sopra esaminate) hanno in modo chiaro espresso l’esistenza di ampi spazi di discrezionalità da parte della società con la sola previsione della misurazione qualitativa ( e non quantitativa) del ristorno attribuibile ai soci in base agli scambi mutualistici e non capitalistici raccordati alla misura dei conferimenti.
NdR: potrebbe interessarti: Il ristorno: l’istituto tipico della società cooperativa
Luciano Sorgato
Lunedì 6 Ottobre 2025

