La Corte di Giustizia UE ha affrontato il tema della legge più favorevole, interrogandosi se il principio della lex mitior, tipico del penale, possa estendersi anche a sanzioni che, pur definite amministrative, incidono come vere e proprie pene. La questione apre scenari inediti sul confine tra amministrativo e penale, sollevando interrogativi cruciali per la tutela dei diritti.
La lex mitior nelle sanzioni amministrative di natura penale: la svolta della CGUE
1. Premessa
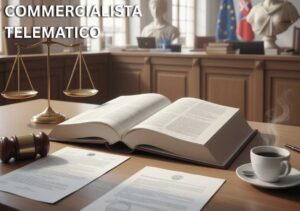
La pronuncia della Corte di Giustizia origina da una richiesta di chiarimenti da parte della Corte suprema amministrativa slovacca, la quale ha chiesto se una sanzione, qualificata come amministrativa secondo la normativa nazionale, dovesse beneficiare di una modifica legislativa più favorevole al condannato, qualora tale modifica fosse intervenuta dopo la decisione che aveva irrogato la sanzione.
Come meglio si dirà nel prosieguo, la Corte di Lussemburgo, interpellata in via pregiudiziale dalla Corte slovacca, ha chiarito che il principio del favor rei (massima espressione del principio della lex posterior mitius) si applica non solo alle sanzioni esplicitamente qualificate come penali, ma anche a quelle formalmente amministrative che, per la loro natura e per le conseguenze che comportano, sono sostanzialmente penali.
Inoltre, la Corte di Giustizia ha ribadito che tale principio si applica fintantoché la condanna non sia divenuta definitiva e, a tal fine, ha chiarito che una condanna non può essere considerata definitiva quando è ancora possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, come il ricorso per Cassazione.
2. Il caso
La controversia in esame trae origine da una sanzione pecuniaria inflitta il 4 novembre 2015 al Sig. T.T., conducente slovacco di un veicolo adibito al trasporto di calcestruzzo, per non aver sottoposto il tachigrafo del veicolo a un controllo periodico obbligatorio, come previsto dalla normativa slovacca all’epoca vigente.
Il conducente impugnava la suddetta sanzione presentando un ricorso gerarchico presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale, nell’aprile 2017, respingeva il ricorso, confermando la validità della sanzione.
Il conducente e la società BAJI Trans (proprietaria del veicolo) impugnavano la suddetta decisione dinanzi la Corte regionale di Bratislava, la quale rigettava il ricorso e confermava la sanzione irrogata.
In particolare, la Corte regionale di Bratislava chiariva che l’obbligo di utilizzare un tachigrafo nei veicoli adibiti a trasporto su strada era previsto dall’art. 3 del Regolamento europeo n. 3821/85, nonché dall’art. 2, par. 1, L. n. 461/2007, fatte salve le esenzioni e le deroghe di cui agli art. 3 e 13 del Regolamento europeo n. 561/2006. Tuttavia, tali deroghe, come chiarito dalla Corte regionale, non comprendevano i veicoli adibiti al trasporto di calcestruzzo.
Il 15 luglio 2019, avverso tale pronuncia, il conducente e la società proprietaria del veicolo proponevano ricorso per Cassazione presso la Corte suprema slovacca.
Nel corso del giudizio di Cassazione, i ricorrenti presentavano memorie in cui evidenziavano una rilevante modifica della normativa europea, in quanto il Regolamento n. 3821/85 è stato abrogato dal Regolamento n. 165/2014 e il Regolamento europeo n. 561/2006 è stato modificato dal Regolamento europeo 2020/1054 in senso loro favorevole.
In altri termini e volendo schematizzare:
- al momento dell’infrazione (novembre 2015) erano applicabili:
-
- il Regolamento n. 3821/85, il quale prevedeva obblighi stringenti in materia di tachigrafi, demandando agli Stati membri l’adozione di un regime sanzionatorio efficace;
- il Regolamento n. 561/2006, il quale elenca le categorie di veicoli adibiti ai trasporti per i quali gli Stati membri possono concedere deroghe e che, nella versione in vigore alla data dell’illecito de quo, non menzionava i veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto all’uso;
-
- a far data dal 2 marzo 2016, il Regolamento 3821/85 è stato abrogato dal Regolamento n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- con decorrenza dal 20 agosto 2020, l’art. 13 del Regolamento n. 561/2006 è stato modificato dal Regolamento n. 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio.
A seguito di tale modifica, il citato art.13, par. 1, menziona, alla lett. r), i «veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l’uso» tra i veicoli che possono essere oggetto di deroghe alle disposizioni degli artt. da 5 a 9 del Regolamento n. 561/2006.
Pertanto, secondo i ricorrenti, tale modifica, introdotta dopo la presentazione del ricorso per Cassazione, aveva come conseguenza che i fatti commessi nel novembre 2015 non integravano più un illecito.
Nel 2021, il caso veniva esaminato dalla Corte suprema amministrativa slovacca, la quale decideva di sospendere il procedimento e sottoporre quattro questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sul punto, si veda il successivo capitolo n. 3).
Interpellata dalla Corte suprema amministrativa slovacca, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulle suddette questioni con la sentenza resa il 1° agosto 2025, fornendo importanti chiarimenti sul principio di retroattività della legge penale favorevole previsto dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
3. Le questioni interpretative sollevate dalla Corte Suprema amministrativa slovacca
Come anticipato, la Corte suprema amministrativa slovacca, nell’esaminare il ricorso presentato dal conducente e dalla società proprietaria del veicolo, si è trovata ad affrontare questioni rilevanti riguardanti l’applicazione del principio della lex posterior mitius e il rapporto tra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea.
A tal fine, giova brevemente rammentare che la controversia nasce dall’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa europea sull’uso del tachigrafo, successivamente modificata in senso più favorevole al destinatario della sanzione.
Ed invero, il Regolamento 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato l’art. 13 del Regolamento n. 561/2006, ampliando l’elenco delle esenzioni previste per determinati veicoli facendovi rientrare anche quelli destinati al trasporto di calcestruzzo, come nel caso oggetto procedimento de quo.
La Corte slovacca si è, dunque, interrogata sull’obbligo di applicare tale disciplina più favorevole nel contesto di un giudizio di legittimità ancora pendente, nonostante la sanzione fosse già stata confermata da una sentenza considerata definitiva secondo il diritto nazionale.
Ebbene, i dubbi interpretativi, che hanno indotto la Corte suprema amministrativa slovacca a sospendere il procedimento e a sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una domanda di pronuncia pregiudiziale, erano i seguenti:
- in primo luogo, la Corte slovacca ha osservato che il principio della lex mitior, sancito dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, può trovare applicazione esclusivamente nei casi in cui lo Stato membro attui il diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della medesima Carta.
Nel caso in esame, poiché le norme nazionali erano state adottate per attuare i Regolamenti n. 3821/85 e n. 165/2014 (che prevedono l’obbligo di istituire un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sul trasporto su strada), il giudice del rinvio ha ritenuto che l’autorità nazionale abbia agito nell’ambito del diritto dell’Unione, sia nella fase di irrogazione della sanzione sia nel successivo procedimento di impugnazione.
Ebbene, secondo il giudice slovacco, il dubbio interpretativo sul punto riguardava la correttezza o meno di tale interpretazione (cfr. par. 37 e 38 della sentenza in commento); - in secondo luogo, la Corte slovacca ha rilevato che, per soddisfare i requisiti di cui all’art. 6 della CEDU, il principio di retroattività della legge penale più favorevole deve essere applicato non solo dalle autorità amministrative incaricate di irrogare sanzioni di natura penale, ma anche dai giudici investiti di un ricorso esteso al merito avverso tali decisioni amministrative.
Lo stesso principio – secondo l’interpretazione prospettata dal giudice nazionale – troverebbe applicazione anche nell’ambito dell’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ebbene, tale dubbio interpretativo atteneva proprio all’ambito di applicazione del citato art. 49, par. 1, ultima frase, che sancisce il principio di retroattività della legge penale più favorevole.
In particolare, secondo la Corte slovacca, non era chiaro se tale disposizione trovi applicazione anche in presenza di sanzioni amministrative che, per la loro natura sostanzialmente penale, rientrano nella nozione autonoma di “materia penale” elaborata dalla giurisprudenza europea (cfr. par. 39 della sentenza in commento);in terzo luogo, secondo la Corte suprema amministrativa, non era chiaro se spettasse ad essa «in quanto giudice di cassazione, prendere in considerazione una legge penale più favorevole che è stata adottata dopo la pronuncia della decisione giurisdizionale considerata definitiva, in forza del diritto nazionale, e contro la quale la BAJI Trans e T.T. hanno proposto impugnazione».
A tal riguardo, il giudice slovacco ha richiamato il principio, già affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la retroattività della legge penale più favorevole si applica ai procedimenti penali pendenti prima di una decisione definitiva, evidenziando, tuttavia, che la Corte non si è ancora pronunciata sul modo di valutare il carattere definitivo di tale decisione.
Sul punto, la Corte suprema amministrativa slovacca ha sottolineato che, secondo il diritto slovacco, il ricorso per Cassazione:-
- è considerato un rimedio straordinario, perché diretto contro una decisione giurisdizionale definitiva;
- è vincolato alla situazione giuridica esistente al momento della pronuncia della decisione stessa;
- contiene motivi enunciati «secondo criteri di ampio respiro e coprono, in linea di principio, tutti i vizi di diritto e procedurali».
-
Inoltre, il giudice del rinvio ha evidenziato che, nel ricorso per Cassazione, la parte ricorrente ha, di norma, diritto ad una pronuncia sul ricorso e a che il procedimento relativo al ricorso per Cassazione segua regolarmente quello dinanzi al giudice amministrativo di grado inferiore.
Ciò chiarito, secondo la Corte slovacca, il dubbio interpretativo riguardava la possibilità di applicare la modifica normativa successiva all’irrogazione della sanzione e più favorevole al destinatario della stessa anche a procedimenti pendenti in Cassazione, pur in presenza di una decisione considerata definitiva dal diritto nazionale (cfr. par. da 40 a 44 della sentenza in commento).
Per tali motivi, la Corte suprema amministrativa slovacca ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:
- se uno Stato membro possa considerarsi come “attuatore del diritto dell’Unione” – e, quindi, soggetto all’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea — nel caso in cui il diritto nazionale preveda una sanzione amministrativa per la violazione di un obbligo che deriva direttamente dal diritto dell’Unione europea e che, secondo la normativa europea (art. 19, par. 1, del Regolamento n. 3821/85 e art. 41, par. 1, del Regolamento n. 165/2014), deve essere effettivamente sanzionato dallo Stato membro.
Nello specifico, nella sentenza in commento, al par. 45, n. 1), così si legge:
«1) Se l’articolo 51, paragrafo 1, della [Carta] debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione quando, secondo il diritto nazionale, preveda una sanzione amministrativa per la violazione di un obbligo, qualora tale obbligo discenda dal diritto dell’Unione e lo Stato membro sia tenuto a sanzionarne la violazione, come previsto all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 3821/85 e all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014»; - in caso di risposta affermativa alla precedente questione sub. a), se l’art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e il principio della lex posterior mitior in esso contenuto trovino applicazione anche nel contesto degli illeciti amministrativi, nei quali la responsabilità dell’autore e la sanzione vengano inizialmente accertate da un’autorità amministrativa e, solo in un momento successivo, sottoposte al controllo di un giudice amministrativo.
In altri termini, la suddetta questione interpretativa riguarda la possibilità di applicare il principio di retroattività della norma penale più favorevole ai procedimenti sanzionatori di natura amministrativa e anche nella successiva fase giurisdizionale di controllo sulla decisione amministrativa.
Nello specifico, nella sentenza in commento, al par. 45, n. 2), così si legge:
«2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano anche all’irrogazione di sanzioni per illeciti amministrativi qualora, in un primo tempo, la colpevolezza e la pena siano decise non da un’autorità giudiziaria, bensì da un’autorità amministrativa, e che tale principio si applica successivamente anche al controllo della decisione di tale autorità amministrativa da parte di un giudice amministrativo.»; - in caso di risposta affermativa alla precedente questione sub. b), se l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e il principio della lex posterior mitior debbano ritenersi applicabili a tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali, a prescindere dalla fase procedimentale in cui essi si trovano.
In altri termini, la questione interpretativa demandata alla Corte di Giustizia è se il principio della retroattività della norma più favorevole possa operare anche quando il procedimento è già in uno stadio avanzato o prossimo alla conclusione.
Nello specifico, nella sentenza in commento, al par. 45, n. 3), così si legge:
«3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se l’articolo 49 della [Carta] e il principio della lex posterior mitius ivi contenuto debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano ai procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali indipendentemente dalla fase in cui si trovano.»; - in caso di risposta negativa alla precedente questione sub. c), quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire in quale momento tale principio cessi di operare. In particolare, se l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e il principio di retroattività della norma più favorevole possano applicarsi anche nell’ambito di un ricorso per Cassazione, come quello pendente davanti alla Corte suprema amministrativa slovacca. In tal caso, il giudice di ultima istanza è chiamato a valutare una sanzione irrogata in origine da un’autorità amministrativa e confermata da un giudice amministrativo di primo grado con una decisione considerata definitiva secondo il diritto nazionale.
Il dubbio riguarda l’ipotesi in cui una modifica normativa favorevole all’autore dell’illecito sia intervenuta solo dopo tale decisione, ma prima della pronuncia del giudice di Cassazione.
Nello specifico, nella sentenza in commento, al par. 45, n. 4), così si legge:
«4) In caso di risposta negativa alla terza questione: in base a quali criteri sarà determinata questa fase? In concreto, se l’articolo 49 della [Carta] e il principio della lex posterior mitius in esso contenuto debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano a un procedimento amministrativo giurisdizionale di ricorso quale il procedimento di ricorso per cassazione, cosicché un organo giurisdizionale come il Najvyšší správny súd [(Corte suprema amministrativa)], investito di un tale ricorso in seconda e ultima istanza, deve tener conto della modifica della normativa a favore dell’autore dell’illecito amministrativo esaminato, nel procedimento di base, dall’autorità amministrativa e non da un giudice, modifica intervenuta solo dopo la pronuncia della decisione del giudice amministrativo di grado inferiore che è definitiva e sottoposta al controllo del [giudice di ultima istanza]».
Pertanto, la Corte suprema amministrativa slovacca, riconosciuta la rilevanza giuridica delle questioni interpretative sopra delineate, ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento de quo e adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea mediante rinvio pregiudiziale.
4. La sentenza della corte di giustizia dell’unione europea del 1° agosto 2025, Causa C-544/23
La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza resa il 1° agosto 2025, all’esito della causa C-544/23, ha esaminato le questioni interpretative sollevate dalla Corte suprema amministrativa slovacca, fornendo importanti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
4.1) La motivazione della sentenza
Al fine di comprendere appieno la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è necessario analizzare la motivazione della sentenza, seguendo il percorso argomentativo adottato dai giudici europei in relazione alle singole questioni pregiudiziali.
4.1.1) Sulla prima questione pregiudiziale (par. 46-58 della sentenza in commento)
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’esaminare la prima questione pregiudiziale, si è concentrata sull’interpretazione dell’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a norma del quale:
«1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze.».
Ciò chiarito, i giudici europei hanno precisato che, ai sensi del citato articolo:
- le diposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione;
- i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al difuori di esse;
- uno Stato membro attua il diritto dell’Unione «quando adempie l’obbligo, sancito da un atto del diritto dell’Unione, di prevedere sanzioni per le violazioni previste da tale atto».
Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di Giustizia, le autorità slovacche,…
…«infliggendo una sanzione amministrativa pecuniaria a T.T. per aver guidato, il 4 novembre 2015, un veicolo adibito al trasporto di calcestruzzo pronto per l’uso senza rispettare gli obblighi di controllo periodico del tachigrafo di cui tale veicolo doveva essere provvisto»,…
hanno attuato il diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 51, par. 1, cit..
Inoltre, i giudici europei hanno sottolineato che anche la normativa nazionale come modificata dal Regolamento n. 2020/1054 (che ha previsto l’esonero dall’obbligo del tachigrafo per i veicoli adibiti al trasporto di calcestruzzo) costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione.
In altri termini, la normativa nazionale in oggetto, sia nella sua formulazione previgente che in quella attuale (come modificata dal Regolamento n. 2020/1054), «attua il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta» e impone il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta stessa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Giustizia ha definitivamente chiarito che l’art. 51, par. 1, cit. deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione quando:
- da un lato, conformemente a quanto previsto dai Regolamenti nn. 3821/85 e 165/2014, infligge una sanzione amministrativa al conducente di un veicolo per violazione, da parte di quest’ultimo, di obblighi imposti da tali Regolamenti;
- dall’altro, esercita la facoltà, riconosciutagli dalla normativa europea, di esonerare dall’osservanza di tali obblighi taluni veicoli adibiti al trasposto per strada.
4.1.2) Sulla seconda questione pregiudiziale (par. 59-94 della sentenza in commento)
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’esaminare la seconda questione pregiudiziale, si è si è soffermata sull’ambito applicativo dell’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il principio di retroattività della legge penale più favorevole (c.d. principio della lex posterior mitius).
Più nello specifico, l’art. 49, par. 1, ultima frase, cit. così dispone:
«Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.».
Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali risulta che tale disposizione si applica al diritto penale.
Tuttavia, i giudici europei hanno chiarito che, ai fini dell’applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, non è determinante la qualificazione della sanzione nel diritto nazionale: ciò che rileva è la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata, da valutare sulla base di tre criteri consolidati nella giurisprudenza europea:
- la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale;
- la natura dell’illecito;
- il grado di severità della sanzione.
Ebbene, con riferimento al primo criterio (qualificazione giuridica dell’illecito), i giudici europei hanno osservato che, nel caso in esame, l’illecito de quo è considerato un illecito amministrativo nel diritto slovacco.
Tuttavia, la Corte di Lussemburgo ha precisato che l’applicazione dell’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si estende…
…«anche per gli illeciti che non sono qualificati come «penali» dal diritto nazionale, a procedimenti e a sanzioni che devono essere considerati di natura penale»…
sulla base dei due ulteriori criteri (natura dell’illecito e grado di severità della sanzione).
Nello specifico:
- con riferimento al secondo criterio (natura dell’illecito), i giudici europei hanno chiarito che occorre valutare la finalità perseguita dalla misura sanzionatoria.
§In particolare, tale criterio comporta di verificare se la sanzione in oggetto persegua una finalità repressiva, caratteristica che è propria di una sanzione di natura penale.
La presenza di una finalità preventiva non esclude la qualificazione penale della sanzione. Al contrario, come precisato dalla Corte, la funzione preventiva è insita nella stessa natura delle sanzioni penali, le quali tendono normalmente a combinare entrambe le funzioni: repressiva e preventiva.
Al contrario, una misura che abbia esclusivamente una funzione compensativa o risarcitoria, cioè che miri solo a ristorare un danno arrecato, non può essere qualificata come penale, in quanto priva dell’elemento repressivo che connota le sanzioni sostanzialmente penali.
Nel caso di specie, i giudici europei hanno osservato che le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione degli obblighi relativi alla presenza e al controllo periodico di un tachigrafo a bordo di taluni tipi di veicoli perseguono obiettivi sia di dissuasione sia di repressione di tali infrazioni, senza essere volte a risarcire il danno da esse causato.
In altri termini, nel caso in esame, pur essendo la sanzione irrogata formalmente qualificata come amministrativa nel diritto slovacco, la Corte di Giustizia ha osservato che essa ha natura penale in senso sostanziale, in quanto:-
- persegue obiettivi repressivi e dissuasivi, tipici delle sanzioni penali;
- non ha carattere meramente risarcitorio;
-
- con riferimento al terzo criterio (grado di severità della sanzione), la Corte ha precisato che il grado di severità della misura adottata deve essere valutato in funzione della pena massima prevista dalla normativa applicabile.
Nel caso di specie, l’infrazione contestata al conducente slovacco – ossia la guida di un veicolo senza tachigrafo sottoposto a controllo periodico – poteva essere punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo massimo di 1.699 euro.
Inoltre, come evidenziato dalle autorità slovacche, la normativa nazionale prevedeva anche la possibilità di accompagnare tale sanzione con il ritiro della patente di guida per un periodo massimo di due anni.
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha chiarito che spetta al giudice nazionale valutare se l’entità complessiva delle suddette sanzioni, considerate congiuntamente, sia tale da renderle sufficientemente gravi da essere considerate di natura repressiva e, quindi, assimilabili, per severità e finalità, a una sanzione penale ai sensi dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Di conseguenza, se, al termine della propria valutazione, il giudice nazionale dovesse concludere che la sanzione pecuniaria irrogata non presenta natura penale, allora non troverebbe applicazione l’art.49 cit..
In tal caso, come si legge nella sentenza in commento, «nessuna norma di diritto dell’Unione imporrebbe, nel caso di specie, il rispetto del principio della lex mitior».
Da tanto ne consegue che, se la sanzione in oggetto non ha natura penale, non può trovare applicazione il principio della lex posterior mitius.
In merito all’applicazione dell’art. 49, par. 1, ultima frase, cit., la Corte di Lussemburgo ha, inoltre, sottolineato che:
«L’applicazione di detta disposizione presuppone quindi una successione di regimi giuridici nel tempo e si fonda sulla constatazione che tale successione rifletta, nell’ambito dell’ordinamento giuridico di cui trattasi, un mutamento di posizione, favorevole all’autore del reato, o in merito alla qualificazione penale dei fatti che possono costituire reato oppure in merito alla pena da applicare a un simile reato (…)».
In altri termini, come chiarito nella sentenza, per poter applicare l’art. 49 cit. è necessario che vi sia stata una successione nel tempo di regimi giuridici e che tale cambiamento normativo esprima un diverso orientamento dell’ordinamento giuridico in senso favorevole alla persona sanzionata.
In particolare, occorre che la nuova normativa rifletta una modifica del giudizio del Legislatore sulla gravità del fatto e intervenga:
- o sulla qualificazione penale del fatto;
- oppure sull’entità della sanzione da applicare.
Solo in presenza di un simile mutamento, e non a fronte di un semplice aggiornamento tecnico o di circostanza, può operare il principio di retroattività della legge penale più favorevole.
Di conseguenza, non rientrano nell’ambito di applicabilità del principio della lex mitior le modifiche normative che si fondano su:
- semplici mutamenti delle circostanze di fatto;
- valutazioni tecnico-economiche non idonee a mettere in discussione la punibilità del comportamento.
Nel caso in esame, come si è detto, il conducente slovacco è stato sanzionato per aver guidato un veicolo per la consegna di calcestruzzo pronto all’uso il cui tachigrafo non era stato sottoposto a un controllo periodico valido, come previsto dalla normativa vigente al momento del fatto (novembre 2015).
Tuttavia, successivamente, il Legislatore dell’Unione ha modificato la disciplina, in particolare con il Regolamento 2020/1054, includendo questa tipologia di veicoli tra quelli per cui gli Stati membri possono concedere deroghe all’obbligo di dotazione del tachigrafo.
In linea con questa evoluzione, anche il Legislatore slovacco ha esonerato tutte le categorie di veicoli elencate dall’art.13 del Regolamento n. 561/2006 – tra cui i veicoli per il trasporto di calcestruzzo -dall’obbligo in questione.
È, dunque, ben evidente, secondo la Corte, che la suddetta modifica normativa non può considerarsi un mero adeguamento tecnico, bensì riflette un mutamento di posizione sostanziale del Legislatore dell’Unione e di quello nazionale circa la necessità di sanzionare tale condotta. Pertanto, tale evoluzione normativa può essere considerata rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Giustizia ha definitivamente chiarito che l’art. 49, par. 1, ultima frase, cit. deve essere interpretato nel senso che può applicarsi anche ad una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, inflitta sulla base di una norma che sia stata successivamente modificata in modo più favorevole per la persona sanzionata. A tal fine, è altresì necessario che tale modifica normativa rifletta un mutamento di posizione sulla qualificazione penale dei fatti commessi dal soggetto sanzionato o sulla pena da applicare.
4.1.3) Sulla terza e quarta questione pregiudiziale (par. 95-114 della sentenza in commento)
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’esaminare le questioni terza e quarta, ha preliminarmente ribadito che il principio di retroattività della legge penale più favorevole (ex art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) trova applicazione fintantoché non sia stata pronunciata una condanna definitiva.
Sul punto, nella sentenza in commento così si legge:
«Infatti, tale regola implica che, a decorrere dalla data a partire dalla quale è stato ritenuto, nell’ordinamento giuridico di cui trattasi, che non fosse più necessario punire o punire così severamente un determinato comportamento, un siffatto cambiamento di valutazione deve applicarsi immediatamente a tutti i procedimenti penali non ancora conclusi con una condanna definitiva.».
Inoltre, la Corte ha chiarito che, sebbene le norme di procedura penale rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.
Pertanto, anche se spetta al diritto dello Stato membro stabilire quando una condanna diventa definitiva, questa nozione deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione.
Ne consegue che:
«(…) la circostanza che una condanna sia considerata definitiva, in forza del diritto nazionale, non è determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta da parte del giudice investito di un ricorso avverso la decisione che ha pronunciato tale condanna.».
Ed invero, i giudici europei hanno chiarito che una condanna non può essere considerata definitiva, ai sensi dell’art. 49, par.1, ultima frase, cit., quando avverso tale condanna è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, vale a dire qualsiasi mezzo di ricorso che rientri nell’iter normale di un processo e che, in quanto tale, costituisca uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere.
Di conseguenza, quando un ricorso per Cassazione è esperibile contro una decisione giurisdizionale, tale decisione diventerà definitiva, ai fini dell’applicazione dell’art. 49, par. 1, ultima frase, cit., solo qualora le parti abbiano esaurito tale rimedio giuridico o abbiano lasciato decorrere il termine per proporre un siffatto ricorso senza averlo proposto.
Pertanto, spiega la Corte:
«(…) l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta implica che un giudice di cassazione è tenuto, in linea di principio, a consentire all’autore di un reato, la cui sanzione rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione, di beneficiare di una normativa penale favorevole a tale autore, anche se tale normativa è entrata in vigore dopo la pronuncia della decisione giurisdizionale oggetto di tale ricorso per cassazione.».
Ciò chiarito, nel caso di specie, i giudici europei hanno osservato che dalla decisione di rinvio risulta:
- da un lato, che il conducente del veicolo in oggetto ha proposto un ricorso per Cassazione dinanzi alla Corte suprema amministrativa slovacca entro il termine fissato dalla normativa nazionale;
- dall’altro, che la Corte suprema amministrativa slovacca dispone della facoltà di annullare la decisione del marzo 2019 della Corte regionale di Bratislava.
Da tanto ne discende che, la suddetta decisione della Corte regionale di Bratislava non può essere considerata una «condanna definitiva», ai fini dell’applicazione dell’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Dunque, la Corte di Giustizia ha chiarito che, se il giudice nazionale dovesse concludere che la sanzione pecuniaria inflitta al conducente ha natura penale, allora sarebbe obbligato ad applicare la normativa più favorevole a quest’ultimo, a prescindere dal fatto che tale normativa sia entrata in vigore successivamente alla decisione, qualificata come definitiva in forza del diritto nazionale, della Corte regionale di Bratislava.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Giustizia ha definitivamente chiarito che l’art. 49, par. 1, ultima frase, cit. deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice di Cassazione è chiamato a decidere su una sanzione amministrativa di natura penale che rientra nell’ambito del diritto dell’Unione, egli deve applicare la norma nazionale più favorevole sopravvenuta, anche se entrata in vigore dopo la decisione impugnata e anche se tale decisione è considerata definitiva secondo il diritto nazionale.
4.2) I principi di diritto enunciati dalla corte di giustizia dell’Unione Europea
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Lussemburgo, con la sentenza resa il 1° agosto 2025, all’esito della causa C-544/23, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che:
uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, infligge una sanzione amministrativa al conducente di un veicolo per violazione, da parte di quest’ultimo, di obblighi imposti da tali regolamenti e, dall’altro, si avvale, successivamente, della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, di esonerare dall’osservanza di tali obblighi taluni veicoli adibiti al trasporto su strada.
2) L’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che:
esso può applicarsi a una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sulla base di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o sulla pena da applicare.
3) L’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che:
un giudice, investito di un ricorso per cassazione avverso una decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una normativa nazionale più favorevole alla persona condannata, che è entrata in vigore dopo la pronuncia di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale.».
I principi di diritto così formulati dalla Corte di Giustizia rivestono particolare rilevanza poiché chiariscono, in modo vincolante per gli Stati membri, la portata dell’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, estendendone l’applicazione anche alle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali.
Inoltre, viene ribadita la necessità di un’interpretazione autonoma e uniforme del concetto di «condanna definitiva» e si consolida il dovere dei giudici nazionali di applicare la normativa più favorevole sopravvenuta, anche successivamente alla decisione impugnata e a prescindere dalle qualificazioni formali previste dal diritto interno.
5. Osservazioni conclusive
Tirando le fila del discorso e volendo schematizzare quanto sin qui argomentato, la recente sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa il 1° agosto 2025, all’esito della causa C-544/23, rappresenta un importante punto di svolta nell’interpretazione delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare in relazione all’applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole (lex posterior mitius).
Ed invero, attraverso un’attenta analisi delle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte suprema amministrativa slovacca, la Corte di Lussemburgo ha affermato con chiarezza alcuni principi di diritto di portata generale, che superano le peculiarità del caso concreto e si impongono come standard interpretativi vincolanti per tutti gli Stati membri.
Più nello specifico, con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che:
- ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:
-
- le diposizioni della citata Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione;
- i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al difuori di esse;
- uno Stato membro attua il diritto dell’Unione quando adempie l’obbligo, sancito da un atto del diritto dell’Unione, di prevedere sanzioni per le violazioni previste da tale atto;
-
- il principio della retroattività della legge penale più favorevole può estendersi anche alle sanzioni formalmente amministrative, qualora esse abbiano natura sostanzialmente penale.
In tale contesto, non è rilevante la qualificazione formale dell’illecito secondo il diritto nazionale, ma piuttosto la sua qualificazione sostanziale, secondo criteri europei; - è necessaria un’interpretazione uniforme del concetto di «condanna definitiva» ai fini dell’applicazione dell’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Nello specifico, la possibilità di esperire un mezzo ordinario di impugnazione, come il ricorso per Cassazione, esclude il carattere definitivo della decisione, obbligando il giudice ad applicare la normativa sopravvenuta più favorevole, anche se intervenuta dopo la pronuncia impugnata.
È ben evidente, dunque, che la sentenza in commento garantisce un’applicazione più ampia e coerente del principio di retroattività della legge penale più favorevole, rafforzando il ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea come parametro imprescindibile di garanzia anche in procedimenti di natura solo formalmente amministrativa.
L’argomento è stato approfondito anche su BLAST nell’articolo: “La Cassazione e la Lex Mitior: arrivano le smentite della CGUE e della Corte Costituzionale”
NdR: potrebbe interessarti anche…
Niente favor rei per le nuove sanzioni amministrative
Sanzioni tributarie: deroga al favor rei confermata dalla Cassazione
di Maurizio Villani e Marta Zizzari – Studio Legale Tributario Villani
Sabato 27 settembre 2025

