Una sentenza europea ha acceso i riflettori sui limiti dei controlli fiscali e sulla necessità di tutelare i diritti fondamentali del contribuente. Il legislatore è intervenuto con nuove disposizioni, ma il risultato appare deludente: le garanzie sono deboli, i poteri dell’amministrazione restano ampi e il controllo giurisdizionale è solo parziale. Il rischio è che la riforma si riveli un’occasione persa per un vero equilibrio tra fisco e libertà individuali.
Verifiche fiscali e tutela del contribuente: il DL 84/2025 non risponde ai rilievi della CEDU
A seguito della sentenza della CEDU del 06 febbraio 2025, il legislatore nazionale è intervenuto con il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, approvato dalla Camera dei deputati il 22 luglio 2025 e trasmesso al Senato, che, a parere dello scrivente, è inutile ed incompleto perché non rispetta i criteri stabiliti dai giudici europei, come cercherò di spiegare nel presente articolo.
Verifiche fiscali: attuale normativa
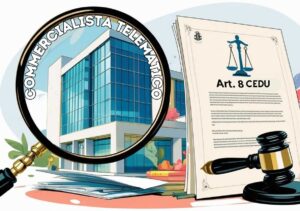
I suddetti articoli, senza richiedere le motivazioni, stabiliscono le seguenti condizioni, con potere discrezionale illimitato:
- preventiva autorizzazione amministrativa;
- autorizzazione del procuratore della Repubblica per gli accessi in locali adibiti anche ad abitazione; secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’autorizzazione rilasciata da un responsabile dell’Agenzia delle Entrate o da un procuratore della Repubblica che permette l’accesso ai locali commerciali e ai locali adibiti ad attività professionali che non costituiscono una dimora privata non deve necessariamente essere motivata, in quanto le pertinenti disposizioni di legge non prevedono presupposti specifici per il rilascio di un’autorizzazione di questo tipo, che è dunque un «mero adempimento procedurale» necessario unicamente affinché la misura «trovi l’avallo di autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata» (si veda Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16424 del 21 novembre 2002; si vedano anche le sentenze della Corte di Cassazione nn. 26829 del 18 dicembre 2014, e 28563 del 6 novembre 2019). Invece, la motivazione è necessaria quando la misura in questione è autorizzata da un procuratore della Repubblica con riguardo a locali destinati ad abitazione privata (si veda Corte di Cassazione, sentenza n. 20096 del 30 luglio 2018);
- autorizzazione del procuratore della Repubblica per gli accessi alle abitazioni private, soltanto in caso di gravi indizi;
- è in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale;
- la Guardia di finanza coopera con gli uffici fiscali per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 32. Essa, inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici fiscali documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 4/1929, gli ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, possono sempre accedere in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria (si veda Corte di Cassazione, sentenze nn. 16017 dell’8 luglio 2009, 10137 del 28 aprile 2010, e 17525 e 17526 del 28 giugno 2019).
L’art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) al secondo comma testualmente dispone:
“Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l’assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Inoltre, il Garante del contribuente, ai sensi dell’art. 13 Legge n. 212/2000, può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dal succitato art. 12.
Infine, l’art. 7-quinquies della Legge n. 212/2000, a far data dal 18 gennaio 2024, testualmente dispone:
“Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.”
Infine, la Corte di Cassazione – Sezione Quinta Civile – con la sentenza n. 1818/2010 ha stabilito i seguenti principi di diritto in tema di verifiche fiscali:
“La censura della ricorrente è fondata perché, per l’articolo detto, “l’atto pubblico” – quindi anche “il processo verbale di constatazione, redatto dalla guardia di finanza, o dagli altri organi di controllo fiscale” avente, indubbiamente (Cass., trib., 10 febbraio 2006 n. 2949), la stessa natura – “fa piena prova” (vincibile solo con la proposizione della “querela di falso”) unicamente quanto alla “provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato”, alle “dichiarazioni delle parti” ed agli “altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In ordine a tale norma, questa Corte (per quanto rileva ai fini dell’esame della censura) ha già precisato che:
- non può essere attribuita “fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né’ alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali” (Cass., 2, 4 novembre 2008 n. 26488, che richiama “Cass., sent. n. 6565 del 2007, n. 20441 del 2006”; cui adde: Cass., 3, 14 aprile 2000 n. 4844);
- “l’atto pubblico”, comunque (Cass., 3, 2 ottobre 2008 n. 24 530), “non prova la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese” al pubblico ufficiale rogante “dalle parti” per cui quelle dichiarazioni “possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che, all’uopo, occorra o possa proporsi, querela di falso (v. Cass. n. 10569/2001)”;
- “resta ovviamente” sempre “fermo il potere del giudice di valutare” le “circostanze” esposte nell’atto assistito da fede privilegiata e ” decidere se esse costituiscano o meno prove della responsabilità oggetto della domanda” (Cass., 3, 18 settembre 2008 n. 23852);
- la fede privilegiata prevista dalla norma non esclude (Cass., 3, 16 giugno 2003 n. 9620) il “il potere – dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l’esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati”;
- “il materiale probatorio” costituito dalle “altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato” è (Cass., lav., 6 giugno 2008 n. 15073) “liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Verifiche fiscali: Corte di Cassazione a sezioni unite – Corte Costituzionale
In tema di verifiche fiscali, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le tre importanti sentenze nn. 6315/2009, n. 11082/2010 e n. 8587/2016, ha stabilito i seguenti principi di diritto:
“In particolare le sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione del giudice tributario ha carattere pieno ed esclusivo e si estende non solo all’impugnazione del provvedimento impositivo ma anche alla legittimità di tutti gli atti del relativo procedimento, ivi compresa l’autorizzazione di cui si discute, sostanzialmente perché l’eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità (formale o sostanziale) su di un atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, dell’atto “finale” impugnato, con la conseguenza che gli eventuali vizi di atti istruttori prodromici possono essere fatti valere dinanzi al giudice tributario soltanto in caso di impugnazione del provvedimento che conclude l’iter di accertamento.
Qualora, invece, l’attività di accertamento non sfoci in un atto impositivo (ovvero, e’ da ritenersi, tale atto, come nella specie, non sia fatto oggetto di impugnazione), secondo le sezioni unite l’autorizzazione in questione, siccome in ipotesi lesiva del diritto soggettivo del contribuente a non subire verifiche fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge, è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice ordinario.
Infine, le sezioni unite hanno precisato che il problema della riconducibilità dell’atto impugnato alle categorie indicate dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, è questione che non attiene alla giurisdizione del giudice adito bensì alla proponibilità della domanda dinanzi a quel giudice.”
“E’ infine appena il caso di precisare che la statuizione di improponibilità del ricorso non crea un vuoto di tutela (ne’ pertanto comporta alcuna violazione della Costituzione e della CEDU), posto che, qualora il procedimento di verifica fiscale non si sia concluso con un provvedimento “tributario” ovvero tale provvedimento non sia stato impugnato dal contribuente, in relazione all’atto “procedimentale” è comunque assicurata la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario, con la possibilità, ricorrendone i presupposti, di agire anche in via cautelare.
Come affermato anche nella più volte citata sentenza di queste sezioni unite, infatti, l’eventuale illegittimità del provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica non lede un semplice interesse legittimo ma integra (se effettivamente sussistente) sempre la lesione di un diritto soggettivo del contribuente nei cui confronti viene eseguita la verifica, perché solo quel provvedimento rende legittimo l’esercizio dell’azione accertatrice e fa sorgere, a carico del contribuente-professionista sottoposto a verifica, l’obbligo di soggiacere a detta azione anche in ordine ai documenti secretati nonché di fare quanto eventualmente le norme gli impongano per consentire agli inquirenti di svolgere appieno la propria attività. L’ipotizzabile esito negativo per l’Ufficio dell’attività di accertamento compiuta in forza di provvedimento ritenuto illegittimo dal contribuente (con conseguente riscontrata inesistenza delle condizioni per emettere un provvedimento fiscale), oppure l’adozione di un provvedimento impositivo del tutto avulso dall’esame dei documenti secretati, ovvero di un provvedimento impositivo che il contribuente non abbia impugnato porta dunque inevitabilmente la valutazione di quel fatto (ove lesivo di un qualche diverso interesse giuridico del contribuente ispezionato) nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario siccome in ipotesi incidente sul diritto soggettivo del contribuente a non subire, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, verifiche fiscali – con relative compressioni legali dei suoi corrispondenti diritti, anche costituzionalmente garantiti – oltre i casi previsti dalle leggi che attribuiscono e circoscrivono l’esercizio del potere di controllo degli Uffici fiscali.”
Inoltre, in ordine alla legittimità del differimento al momento della impugnazione dell’atto impositivo della tutela giurisdizionale per vizi e/o per irregolarità concernenti atti compiuti nel corso dell’iter amministrativo conclusosi con l’adozione dell’atto impositivo notificato, di poi, è sufficiente ricordare il pensiero (“costantemente affermato”, come dice lo stesso giudice delle leggi) della Corte Costituzionale (decisione 23 novembre 1993 n. 406, che ricorda “da ultimo le sentenze n. 154 del 1992; n. 15 del 1991; n. 410 del 1990; n. 530 del 1989”) secondo cui:
“gli articoli 24 e 113 Cost., non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale può essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia”,
sempre che:
“il legislatore” osservi “il limite imposto dall’esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, in conformità al principio della piena attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme costituzionali”.
Verifiche fiscali: normativa CEDU e corte CEDU (Italgomme)
L’art. 8 della Legge n. 848 del 04 agosto 1955 di ratifica ed esecuzione della CEDU, testualmente dispone:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Prima sezione – con l’importante sentenza del 06 febbraio 2025 ha deciso quanto segue (paragrafi nn. 147 – 148 e 149):
“Per questi motivi, alla luce della sua constatazione di violazione dell’articolo 8 della Convenzione (si veda il paragrafo 139 supra), la Corte ritiene che sia di fondamentale importanza che lo Stato convenuto adotti le misure generali appropriate al fine di adeguare la propria legislazione e la propria prassi alle conclusioni della Corte. In questo contesto, la Corte ritiene che le seguenti questioni debbano essere chiaramente disciplinate nel quadro giuridico interno. In particolare, la Corte ritiene che la maggior parte delle misure necessarie siano già previste dalla normativa nazionale, in particolare dagli articoli 12 e 13 della legge n. 212/2000 (si veda il paragrafo 53 supra), ma che i principi generali enunciati in tale normativa debbano essere attuati mediante norme specifiche nel diritto interno, mentre la giurisprudenza dovrebbe essere allineata a tali principi e a quelli stabiliti dalla Corte.
In primo luogo, il quadro giuridico interno, se necessario mediante indicazioni di prassi amministrativa pertinenti, dovrebbe indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a procedere a verifiche in loco e a controlli fiscali sui locali commerciali e sui locali adibiti ad attività professionali (si veda il paragrafo 97 supra). Tuttavia, la severità dei criteri imposti dalla legge può tenere conto del fatto che, in ambito fiscale, delle considerazioni di efficienza potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti tributari (si veda il paragrafo 99 supra). Tuttavia, il quadro giuridico interno dovrebbe imporre alle autorità nazionali l’obbligo di fornire una motivazione, e dunque di giustificare la misura in questione sulla base di tali criteri (si veda il paragrafo 113 supra). Anche se, in materia fiscale, i controlli e le verifiche possono andare oltre il semplice controllo delle scritture contabili obbligatorie (si veda il paragrafo 118 supra), dovrebbero essere stabilite delle garanzie per evitare l’accesso indiscriminato, o almeno la conservazione e l’utilizzo di documenti e oggetti non connessi con l’obiettivo della misura in questione, fatto salvo l’esercizio del potere delle autorità di avviare dei procedimenti amministrativi separati o, se del caso, dei procedimenti penali (si vedano i paragrafi 98 e 119-120 supra). Qualora la legislazione nazionale non distingua tra verifiche o ispezioni annunciate o programmate prima e verifiche o ispezioni di cui il contribuente non è informato in anticipo (si veda, a contrario, Rustamkhanli, sopra citata, 21), il contribuente, al più tardi al momento dell’avvio della verifica, deve avere il diritto di essere informato dei motivi che la giustificano e della portata della stessa, del suo diritto di essere assistito da un professionista, e delle conseguenze del suo eventuale rifiuto di autorizzare la verifica. Quanto precede non pregiudica il potere delle autorità di accedere ai dati relativi al contribuente che sono stati ottenuti legittimamente mediante l’accesso a banche dati fiscali, a banche dati bancarie e finanziarie, e alla cooperazione con altre autorità, anche su base transfrontaliera.
In secondo luogo, il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata (si veda il paragrafo 101 supra). La Corte, dopo aver preso atto delle varie restrizioni alla competenza dei giudici tributari e civili (si vedano i paragrafi 127‑130 e 133‑134 supra), ritiene che l’esistenza e la disponibilità di tali ricorsi non debbano essere subordinate al fatto che una misura abbia portato all’emissione di un avviso di accertamento (si veda il paragrafo 128 supra), e che gli stessi ricorsi non dovrebbero essere disponibili solo al termine della procedura di accertamento fiscale (si veda il paragrafo 129 supra). Se un contribuente ritiene che le persone che procedono a un controllo non agiscano conformemente alla legge – possibilità già menzionata nell’articolo 13 della legge n. 212/2000 – dovrebbe essere disponibile una qualche forma di revisione semplificata intermedia e vincolante prima che il controllo sia completato.”
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, giustamente la Corte CEDU ha dichiarato, all’unanimità, che vi è stata una violazione del citato art. 8 della Convenzione.
Infine, la Corte CEDU ha precisato quanto segue (paragrafo 145):
“Ai sensi dell’articolo 46 §§ 1 e 2 della Convenzione, una sentenza nella quale la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli comporta, per lo Stato convenuto, l’obbligo giuridico di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, eventualmente, individuali, da adottare nel proprio ordinamento giuridico interno allo scopo di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze, in maniera tale da ripristinare per quanto possibile la situazione antecedente a quest’ultima. Inoltre, dalla Convenzione, e in particolare dall’articolo 1 di quest’ultima, risulta che, ratificando la Convenzione e i suoi Protocolli, gli Stati contraenti si impegnano a far sì che il loro diritto interno sia compatibile con questi ultimi (si vedano, tra altre, Maestri c. Italia [GC], n. 39748/98, § 47, CEDU 2004-I, e Ekimdzhiev e altri c. Bulgaria, n. 70078/12, § 427, 11 gennaio 2022). Sotto il controllo del Comitato dei Ministri, lo Stato convenuto rimane libero di scegliere quali mezzi utilizzare per adempiere agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell’articolo 46 § 1 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le «conclusioni e lo spirito» della sentenza della Corte (Ilgar Mammadov c. Azerbaijan (procedura di infrazione) [GC], n. 15172/13, § 153 e 195, 29 maggio 2019). Tuttavia, per aiutare lo Stato convenuto ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 46, la Corte può cercare di indicare delle misure individuali e/o generali che potrebbero essere adottate per porre fine alla situazione constatata (si veda Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, § 255, CEDU 2012, con gli altri riferimenti ivi citati).”
Corte di cassazione – Sezione tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 11910 del 06/05/2025
La Corte di Cassazione – Sezione tributaria – con l’ordinanza interlocutoria n. 11910/2025, proprio alla luce della succitata sentenza della Corte CEDU, ha precisato quanto segue:
“In via preliminare deve rilevarsi che, successivamente all’udienza di discussione ed alla riserva della decisione da parte di questa Corte, è sopravvenuta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nella causa It.Pn. Srl e altri c. Italia, ricorsi 36617/2018 e altri 12) sulla questione della violazione dell’art. 8 della CEDU da parte dell’Italia in materia di ‘accessi’, ‘ispezioni’ e ‘verifiche’ delle autorità italiane presso i locali della società o, comunque, adibiti all’esercizio dell’attività professionale (disciplinati dagli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/1972 e 32 e 33 D.P.R. n. 600/1973).
La sentenza, non ancora definitiva, per non essere scaduto il termine di 90 giorni previsto dall’art. 44, par. 2, della Convenzione, dopo aver premesso che ‘secondo costante giurisprudenza, sebbene l’articolo 8 della Convenzione, non contenga requisiti procedurali espliciti, il processo decisionale che conduce alle misure di ingerenza deve essere equo e tale da rispettare gli interessi tutelati al singolo dall’articolo 8’, ha affermato, in particolare, i seguenti principi:
- ‘l’articolo 8 deve essere interpretato nel senso che include il rispetto della sede legale, delle succursali o di altri locali commerciali di una società (…) nonché il rispetto dei locali adibiti all’attività professionale’;
- pur non essendo equivalenti a perquisizioni e sequestri, le misure (ovvero gli accessi ai locali commerciali e le verifiche ivi effettuate) costituiscono una ‘ingerenza’ nel diritto dei ricorrenti al rispetto del loro ‘domicilio’ e della loro ‘corrispondenza’ ai sensi dell’art. 8 della Convenzione;
- ‘si riconosce che le autorità nazionali dispongono di un margine di discrezionalità più ampio quando si tratta dei locali commerciali di una persona giuridica o di locali adibiti ad attività professionali, piuttosto che quelli di una persona fisica’;
- le garanzie previste per le perquisizioni e le ispezioni in generale ‘si applicano in modo meno rigoroso alle verifiche fiscali in loco’, ma in ogni caso ‘i poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali non possono essere interpretati nel senso di conferire all’amministrazione finanziaria un potere discrezionale illimitato’;
- in generale il difetto di una autorizzazione giudiziaria preventiva può essere compensata da altre garanzie efficaci contro gli abusi, come una procedura di reclamo soggetta a controllo giurisdizionale;
- nella specie ‘le misure impugnate’ hanno un fondamento giuridico nel diritto interno, sia per quanto riguarda la Guardia di finanza (art. 35 L. 4/1929) sia per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate (artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/1972 e 33 e 33 D.P.R. n. 600/1973), ma le condizioni indicate nella norme ‘non sono sufficienti a delimitare la portata del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali’; pertanto, la base giuridica delle misure impugnate non è ‘in grado di delimitare in modo sufficiente l’ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali e, di conseguenza, non soddisfa il requisito di “qualità del diritto” di cui all’articolo 8 della Convenzione;
- pur ribadendo la necessità di consentire poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti tributari ‘tali competenze devono essere delimitate in modo da evitare un margine di discrezionalità illimitato’;
- nella specie il quadro giuridico interno non fornisce garanzie adeguate ed efficaci contro la Guardia di finanza e l’Autorità fiscale, che esercitano un ‘potere discrezionale illimitato’, non essendo regolamentato il loro potere di valutare, in relazione all’accesso ed all’ispezione, ‘l’adeguatezza, il numero, la durata e la portata di tali operazioni e delle informazioni richieste ai contribuenti’;
- infine, la mancanza di un’autorizzazione giudiziaria preventiva non è bilanciata da altre garanzie effettive ed adeguate contro gli abusi e l’arbitrarietà, ovvero da un controllo giurisdizionale ex post della loro legittimità, necessità e proporzionalità.”
Dopo il deposito delle controdeduzioni delle parti ricorrenti, si è in attesa della sentenza della Corte di Cassazione – Sezione tributaria.
A tal proposito, si fa presente che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce – Sezione 23, su richiesta mia e dell’ufficio fiscale, con le due ordinanze del 18 luglio 2025 ha rinviato le due cause all’udienza del 15 dicembre 2025 per conoscere la pronuncia della suddetta Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
Di conseguenza, è consigliabile che le parti processuali nei vari processi sull’argomento chiedano il rinvio.
Disegno di legge n. 1376 dell’11/02/2025 comunicato alla Presidenza del Senato l’11/02/2025 dai senatori Zanettin e Gasparri
Il disegno di legge n. 1376/2025 presentato al Senato reca disposizioni in materia di rafforzamento del rispetto del domicilio e del diritto di difesa del contribuente nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale, in base alle seguenti proposte legislative:
“DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1 – Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 52:
- al primo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto»;- al secondo comma, dopo le parole: «previa autorizzazione del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti:
«motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto,»;- al terzo comma, dopo le parole: «o dell’autorità giudiziaria più vicina» sono inserite le seguenti: «motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto,»;
- dopo l’articolo 52 è inserito il seguente: «Art. 52-bis. – 1. (Tutela giurisdizionale in materia di accessi domiciliari e acquisizioni documentali) – Il contribuente nei cui confronti sia stato eseguito, ai sensi dell’articolo 52, commi dal primo al terzo del presente decreto, un accesso presso locali adibiti in tutto o in parte ad abitazione ovvero che sia stato sottoposto, durante l’accesso, a perquisizioni personali o all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili o alla richiesta di esame di documenti o di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, entro venti giorni dall’esecuzione delle suddette attività, può proporre, con istanza motivata, al presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per territorio in ragione della circoscrizione in cui ha sede l’Ufficio dell’ente impositore procedente, richiesta di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria competente e conseguente dichiarazione di inutilizzabilità delle risposte rese dal contribuente medesimo nonché della documentazione, delle scritture e dei libri o registri acquisiti in copia o sequestrati.
2 – L’istanza di cui al comma 1 deve essere notificata, anche tramite il servizio postale, all’Ufficio dell’ente impositore procedente, il quale, entro venti giorni dalla notifica, può depositare proprie memorie e documenti.
3 – Il presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado decide con sentenza.
4 – Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle corti di giustizia tributaria, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell’ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili».Art. 2.
1 – All’articolo 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dell’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 52 e 52-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Art. 3.
1 – All’articolo 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
« Durante l’accesso in locali adibiti in tutto o in parte ad abitazione per lo svolgimento di perquisizioni personali o apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili nonché per la richiesta di esame di documenti o di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, si applicano gli articoli 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli articoli 52 e 52-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»”
Di conseguenza, a seguito delle suddette modifiche, il citato nuovo art. 52, primo, secondo e terzo comma, del D.P.R. 633/1972, testualmente dispone:
“1. Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. (1)
2. L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto, per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.”.
Il suddetto disegno di legge è inutile ed incompleto perché non rispetta i principi indicati dalla succitata sentenza della Corte CEDU.
Infatti:
- limita la specifica motivazione soltanto all’autorizzazione del procuratore della Repubblica;
- non indica chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e ad effettuare verifiche in loco e controlli fiscali sui locali commerciali e sui locali adibiti ad attività professionali;
- manca l’obbligo generalizzato di fornire una specifica ed adeguata motivazione dei gravi indizi e di giustificare di conseguenza la verifica fiscale;
- non è previsto che il contribuente, al più tardi al momento dell’avvio della verifica, deve avere il diritto di essere informato dei motivi che giustificano la verifica stessa e della sua portata, del suo diritto di essere assistito da un professionista e delle conseguenze del rifiuto di autorizzare la verifica;
- limita il contenzioso tributario al secondo grado e soltanto per le autorizzazioni del procuratore della Repubblica;
- infine, non prevede l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni a tutti i giudizi tributari pendenti.
Decreto legge n. 84/2025 (scade il 16/08/2025)
Il Decreto Legge n. 84/2025, approvato dalla Camera dei deputati il 22 luglio 2025 e trasmesso al Senato, ha aggiunto l’art. 13-bis, che testualmente dispone:
ARTICOLO 13-bis (Emendamento 13.08)
Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso
“La norma integra l’articolo 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali), comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), prevedendo che negli atti di autorizzazione e nei verbali delle operazioni di verifica fiscale siano espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso a locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Tali disposizioni si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Di conseguenza, il nuovo art. 12, comma 1, della Legge n. 212/2000 testualmente dispone:
“1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.”
Il suddetto Decreto Legge n. 84/2025 è inutile ed incompleto perché ignora totalmente i seguenti principi giuridici stabiliti dalla Corte CEDU nella succitata sentenza del 06 febbraio 2025:
- “Affinché il diritto interno soddisfi tali requisiti, deve offrire una misura di protezione giuridica contro le interferenze arbitrarie delle autorità pubbliche con i diritti garantiti dalla Convenzione. Nelle questioni che riguardano i diritti fondamentali, sarebbe contrario allo Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica sancito dalla Convenzione, che una discrezionalità giuridica concessa all’esecutivo si esprima in termini di un potere illimitato. Di conseguenza, la legge deve indicare con sufficiente chiarezza la portata di tale potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio. Il livello di precisione richiesto alla normativa nazionale – che non può in ogni caso prevedere ogni eventualità – dipende in larga misura dal contenuto dello strumento in questione, dal settore cui è destinato a coprirsi, dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari (v. Bernh Larsen Holding AS e a., sopra citata, § 124, con ulteriori riferimenti).”
- “In ogni caso, non è necessario che la Corte esamini in dettaglio i criteri stabiliti nelle presenti linee guida, in quanto non può non rilevare che, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, il rispetto di tali criteri non è una condizione per la legittimità dell’autorizzazione di tali misure, in quanto non è richiesta alcuna motivazione (v. punto 109 sopra). Ne consegue che le disposizioni nazionali pertinenti, anche integrate dagli orientamenti amministrativi pertinenti, non imponevano alle autorità di giustificare l’esercizio dei loro poteri e consentivano quindi loro di esercitare un potere discrezionale illimitato (v. Bernh Larsen Holding AS e a., sopra citata, § 130).”
- “In questo contesto, la Corte ha rilevato che, laddove il diritto interno non richiedesse un’autorizzazione giudiziaria preventiva, ciò potrebbe essere compensato da altre garanzie efficaci e adeguate contro gli abusi, come una procedura di reclamo soggetta a controllo giurisdizionale”.
- “In secondo luogo, il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata (cfr. paragrafo101 sopra). La Corte, dopo aver preso atto delle diverse restrizioni alla competenza dei giudici tributari e civili (v. 127-130 e 133-134 ritiene che l’esistenza e la disponibilità di tali mezzi di ricorso non debbano essere subordinate al fatto che una misura abbia portato disponibili solo una volta concluso il procedimento di accertamento (v. punto129 sopra). Se un contribuente ritiene che le persone che effettuano un controllo non agiscano in conformità con la legge – possibilità già menzionata nell’articolo 13 della legge n. 212/2000 – dovrebbe essere disponibile una qualche forma di riesame intermedio e vincolante semplificato prima che il controllo sia completato.”
Il suddetto Decreto Legge è inutile ed incompleto perché non rispetta i principi indicati dalla succitata sentenza della Corte CEDU.
Infatti:
- manca l’obbligo generalizzato di fornire una specifica ed adeguata motivazione dei gravi indizi e di giustificare di conseguenza la verifica fiscale;
- non è previsto che il contribuente, al più tardi al momento dell’avvio della verifica, deve avere il diritto di essere informato dei motivi che giustificano la verifica stessa e della sua portata, del suo diritto di essere assistito da un professionista e delle conseguenze del rifiuto di autorizzare la verifica;
- non viene prevista alcuna sanzione esplicita per l’inosservanza del nuovo precetto;
- non è prevista l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in modo illegittimo ed immotivato;
- non viene prevista alcuna tutela immediata;
- non viene prevista la possibilità di impugnare subito il processo verbale di verifica con la necessaria modifica dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992;
- infine, non prevede l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni a tutti i giudizi tributari pendenti.
NdR: potrebbe interessarti anche…Verifiche fiscali italiane: violazione delle norme CEDU
Avv. Maurizio Villani
Sabato 9 agosto 2025

